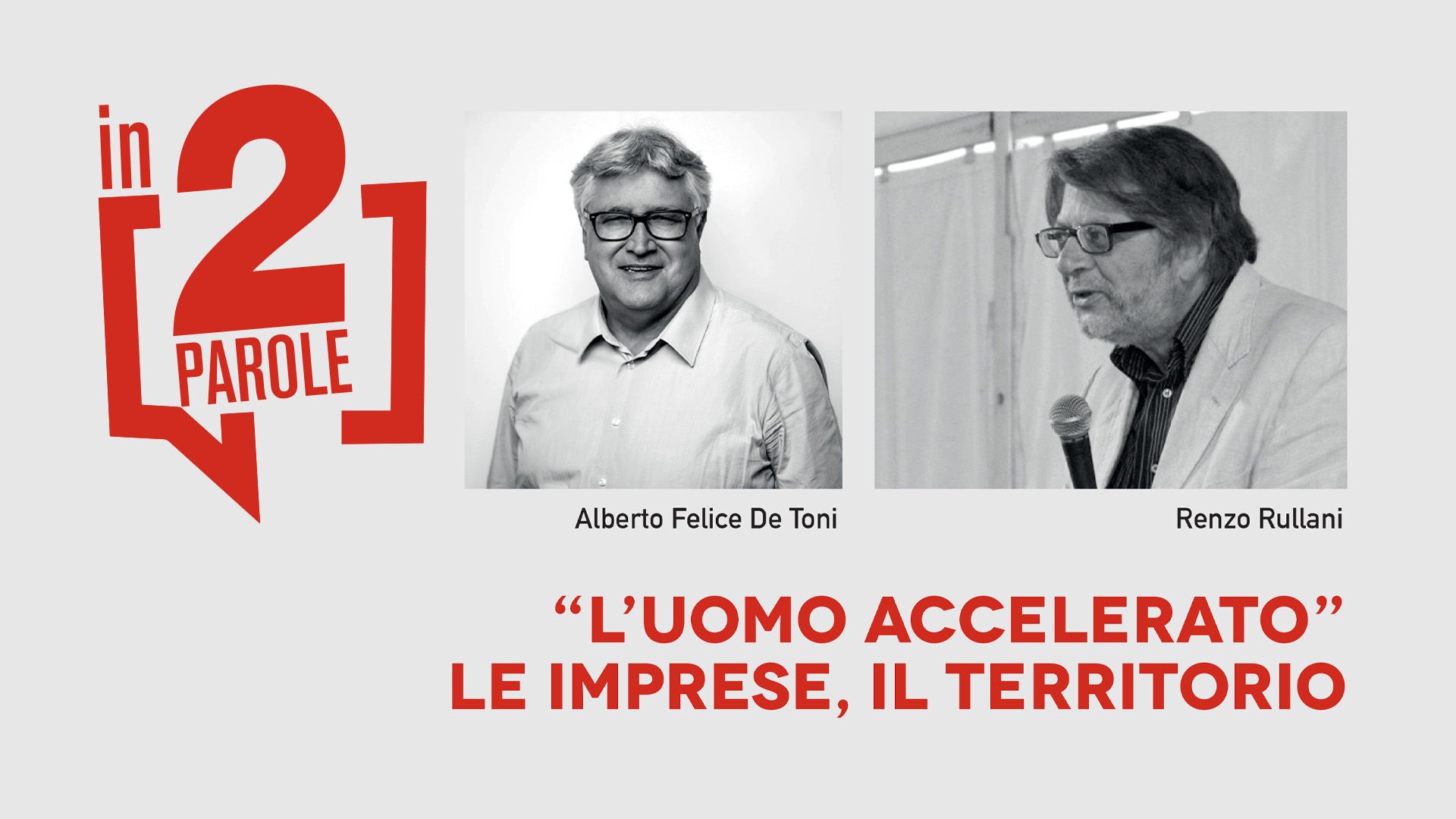
L’uomo accelerato: come l’IA sta cambiando le imprese e il territorio
Il territorio del nord est è un luogo in cui lo sviluppo è stato più volte definito un “miracolo italiano”, i cui protagonisti sono gli imprenditori artigiani e le loro famiglie.
Perché è un mondo di rapporti, cultura, manualità, tecnologie, esperienze che si intrecciano nello stesso territorio. Dalla meccanica all’automazione, dalla concia, alle calzature, alla ceramica…specializzazioni e competenze che fanno parte del territorio e che si trasmettono di generazione in generazione creando filiere e dove si concentrano anche tecnologie e i servizi necessari per quella produzione. Un contesto che l’Intelligenza Artificiale sta trasformando a velocità vertiginosa, automatizzando processi, migliorando le decisioni, potenziando la collaborazione tra aziende e ottimizzando le filiere. Tuttavia, l’adozione dell’IA richiede di gestire una crescente complessità tecnologica, organizzativa ed etica. Questi gli spunti della Conversazione promossa da Confartigianato e che ha visto due protagonisti d’eccezione: Alberto Felice De Toni e Renzo Rullani che hanno approfondito questi temi anche in “Uomini 4.0.: ritorno al futuro” edito da Franco Angeli.
Le riflessioni
Enzo Rullani (sintesi dell’intervento)
L’IA è l’ultima (per ora) tappa di una storia di cambiamenti a cui le imprese, anche piccole e medie, si sono adattate. Quindi, proprio come per gli altri cambiamenti, rimane fondamentale capire bene di che si tratta, cos’è l’Intelligenza Artificiale perché spesso la si usa o se ne parla senza conoscerla. Diversamente a quello che storicamente conosciamo, oggi siamo di fronte a macchine che apprendono e non si limitano a eseguire, che simulano il problema che viene loro posto cercando una risposta. In pratica è il contrario di una machina fordista. Non è quindi una macchina che ha una conoscenza astratta e che porta avanti in autonomia, ma una macchina che se sbaglia cambia (impara). Nelle grandi aziende la conoscenza di queste nuove macchine è delegata a un piccolo gruppo di persone che le studiano e utilizzano per adattarle alla produzione. Il problema sono le aziende che non capiscono le potenzialità dell’IA e quindi rifiutano di approfondirne la conoscenza. Questo atteggiamento non permette di evolvere con il rischio, sempre più reale, di rimane indietro.
Tutto questo porta da un lato a un grande cambiamento del rapporto uomo-macchina dall’altro alla sfida dell’azienda autonoma che, con l’IA, si organizza, conosce e valuta i fornitori e clienti, e che se sbaglia corregge il tiro.
In ballo c’è la competitività delle imprese, non è solo questione di costi ma di utilità e qualità di ciò che sto cercando e producendo. L’uomo non è più davanti alla macchina ma al suo fianco, diventa agente, colloquia con essa (ed essa con l’imprenditore) dicendole cosa evitare, dove accelerare, cosa togliere… La prospettiva rispetto al passato cambia radicalmente.
Con il fordismo arrivò la produzione di massa. I macchinari si basavano tutti sulla tessa conoscenza (erano costruiti in maniera simile) e sugli stessi utilizzi. Obiettivo: massimo risultato minimo sforzo. Ma questa efficienza (quantitativa) nel tempo la si paga con la rigidità. Appunto con prodotti uguali per tutti… di massa. Cambiare vuol dire rivoluzionare macchine, procedure….
Oggi assistiamo a una produzione sempre più personalizzata, campo in cui l’artigianato ha ampio spazio di manovra, in cui vengono riscoperti anche mestieri, lavorazioni e saperi addirittura di tipo pre-industriale. Saperi che esprimono complessità, variabilità, interdipendenza e adattamento. Con il metodo fordista le complessità venivano eliminate, perché troppo dispendioso farvi fronte. E la filiera? Deve essere vicina per reazioni con flessibilità. Questa è la forza del territorio.
Ridurre la complessità è la cifra della scienza e dell’industria dall’800 in poi e che ha portato al mondo fino ad oggi caratterizzato dalla standardizzazione. Con l’IA cambia tutto: arriva la personalizzazione. Il cliente desidera una cosa (e posso anche intuire cosa visto la mole di dati a disposizione) e sono in grado di fornirgliela. Al momento si è in una fase si sperimentazione, si tratta di una transizione e sarà difficile, o meglio impossibile, tornare indietro.
Cosa deve fare allora l’imprenditore? Deve informarsi, e informare chi lavora con lui, e assumersi anche in questo caso dei rischi. Di certo non può stare a guardare. E’ solo con il rischio, con la gestione della complessità, che si cerano catene di valore e quindi di vendita.
D’altronde l’imprenditore lo fa ogni giorno da sempre quando decide di lanciare un prodotto, di scegliere un fornitore, o un cliente.
Va chiarito poi che l’IA non sostituisce l’uomo, come molti temono. Questo perché ai robot mancano tre cose. La prima è appunto saper gestire la complessità (e non eleminarla a prescindere). La seconda è l’autoreferenzialità, ovvero una cosa piace ed ha valore secondo sistemi biologici e culturali diversi da gruppo a gruppo da persona a persona. La terza è l’assunzione della responsabilità (ovvero chi gestisce il rischio delle scelte) se la macchina esce dalle risposte standard (perché, come, quanto…).
Alberto Felice De Toni (sintesi dell’intervento)
Più aumenta la tecnologia più aumenta il ruolo dell’essere umano. Se molte cose senza la tecnologia oggi non sono fattibili né realizzabili, l’avvento di nuove tecnologie porta con sé sempre nuove opportunità. In 40 anni abbiamo conosciuto tre scenari diversi: le tecnologie flessibili che hanno permesso grandi lavorazioni e innovazioni produttive; nel 2000 è arrivato internet, ora c’è l’IA. Quest’ultima rivoluzione si può definire come un quarternario digitale in quanto riassume in sé e opera nei tre settori produttivi (agricoltura, industria, commercio e servizi).
Ognuno dei tre scenari sopraddetti porta con sé un lato oscuro e uno ‘chiaro’. Nell’automazione il lato oscuro è la disoccupazione digitale, quello chiaro l’efficienza produttiva. Nella ‘rivoluzione’ digitale il lato oscura sono i monopoli digitali (che possono anche concentrare ed esprimere potere politico) di fatto spazzando via le norme antitrust, mentre il lato chiaro sono gli innumerevoli servizi gratuiti all’utente. Il quaternario digitale porta con sé l’impreparazione (o la preparazione di pochi) ma dall’altro lato apre a molte opportunità di nuovi business.
Questi nuovi business possono essere espressi in servizi e prodotti nuovi e a costi diversi. E in questi si innesta il concetto di ‘human dreaming’ ovvero bellezza, estetica, autenticità, emozioni, cultura, tradizione…fattori intangibili e non tecnologici. Si tratta di elementi di cui il consumatore tiene conto, accanto ad alte prestazioni tecnologiche, nella scelta dei prodotti da acquistare. Per questo a livello di lavoro serviranno sì tecnici preparati per l’Intelligenza Artificiale ma anche di umanisti in grando di intercettare questi elementi.
Quanto all’IA e all’impatto sulle imprese, piccole e medie, nella manifattura gli esempi non mancano e vanno nel segno dell’efficienza. Per esempio nelle applicazioni per il controllo della qualità e riduzione degli scarti, nella manutenzione predittiva dei macchinari (che riduce del 40% i costi di manutenzione), nel design generativo (per esempio per piastrelle, gioielli, scarpe…), nella tracciabilità dei prodotti, nelle analisi di trend di mercato, nel grossare i temi per conoscere i diretti competitor e dare un’offerta nuova. Tutte cose queste che già molte imprese, anche di piccole e medie dimensioni, stanno facendo. Le pmi possono trarre molti vantaggio dall’IA a patto che tutta la filiera interna sia formata e informata e che la conoscenza non sia limitata.
Curriculum degli ospiti
Alberto Felice de Toni
E’ Professore Emerito di Ingegneria Economico Gestionale presso l’Università di Udine dove insegna “Gestione dei Sistemi Complessi”. È anche Direttore Scientifico di CUOA Business School e membro dell’Academia Europæa. È stato Magnifico Rettore, Presidente della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Presidente dell’AiIG (Associazione italiana di Ingegneria Gestionale), Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Centro Alti Studi per la Difesa e membro dello Strategic Steering Committee dell’European University Institute. Attualmente è anche Sindaco civico del Comune di Udine e componente dell’Ufficio di Presidenza ANCI con delega all’Università e Ricerca.
Enzo Rullani
È Senior Researcher dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Fellow della Viu-Venice International University. In passato ha lavorato come docente e come ricercatore presso le Università Ca’ Foscari, Bocconi, San Raffaele, Verona, Udine, Padova. È stato Visiting Scholar presso il MIT di Boston. È socio onorario della Società Italiana di Management.

